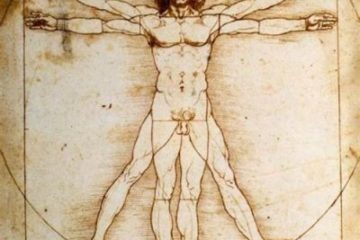Cappuccetto Rosso: una delle più belle fiabe di sempre, scolpita nell’immaginario simbolico di ogni bambino e adulto. Come ogni fiaba, Cappuccetto Rosso è veicolo di simboli ancestrali dell’inconscio collettivo di junghiana memoria (interessante in questo senso la lettura di Marie-Louise von Franz ne Le fiabe interpretate). Una fiaba analizza il funzionamento inconscio della mente umana in maniera quasi chirurgica. L’arte chirurgica e la scienza dei simboli hanno questo in comune: si tratta di arti difficili e lunghe (Vita brevis, ars longa). La comprensione di un simbolo, la decifrazione di un enigma, è dunque opera di una vita, come ben sanno esoteristi, scienziati e letterati.
Alcuni lettori hanno voluto collegare la storia di Cappuccetto a un evento di cronaca nera risalente a qualche secolo fa, in cui venne ritrovata nei boschi una fanciulla con un mantello rosso, in condizioni che non stiamo qui a precisare. Tuttavia probabilmente è il caso di cronaca nera ad essere l’effetto, e non la favola: a dispetto della mentalità bruta e materiale, è più plausibile che la diffusione universale a livello inconscio di certi simboli abbia poi portato a realizzare sul piano concreto certi riferimenti.
Nel libro Cappuccetto Rosso, una fiaba vera, di S. Calabrese e D. Feltracco si esaminano appunto tali questioni. Ma una fiaba non è vera perché prende le mosse da un fatto “reale” a livello empirico. Ciò presuppone un pensiero ingenuo, positivista, che considera primo nell’ordine logico e cronologico il livello dei fatti sensibili. Questo è un pre-giudizio o un presupposto tutto da verificare, che nessun genuino pensatore può dare per scontato. Cosa è vero, cosa è reale? La risposta a questa domanda non è scontata.
Detto questo, torniamo alla nostra fiaba.
Partiamo dal titolo: Cappuccetto Rosso. Questo cappuccio rosso, da cosa deriva? Il mito tramandatoci da Grimm e Perrault non lo dice. Le varie spiegazioni psicanalitiche alludono alla sessualità della storia, esplicita in Perrault: il lupo è la bestia, l’aspetto più carnale della vita umana, la tentazione sovrana a cui tutti siamo esposti.Il rosso sarebbe perciò quella dimensione vietata, repressa, il rosso sangue della carne e delle pulsioni istintive. In questo senso, nella morale puritana dell’Europa moderna, Cappuccetto Rosso sarebbe la ragazza cattiva che va a letto con il Lupo (e difatti il finale di Perrault esprime alla lettera quest’orientamento). Il rosso sarebbe l’inclinazione verso il demoniaco, come nella fiaba Scarpette rosse di Andersen, e porta alla perversione la purezza dell’anima degli innocenti (non è un caso che molta storia dell’arte veda nella donna dai capelli rossi l’incarnazione del Male, resa talvolta nella forma del vampiro).
Negli studi sulle fiabe, quel rosso dello chaperon è interpretato come un blind motive, ovvero un puro abbellimento letterario del testo. In sostanza, un dettaglio inutile. Davvero si tratta di puro ciarpame decorativo?
In realtà il rosso, soprattutto nell’alchemica trilogia rosso-bianco-nero, compare prepotentemente nelle storie più enigmatiche e significative. Rossi sono gli occhi del corvo nero che si poggia sulla statua bianca di Minerva, da Basile a Poe; rosse sono le labbra della bella Biancaneve dagli occhi d’ebano; e gli esempi si potrebbero moltiplicare. Qualcuno ha rintracciato un antecedente illustre del celebre cappello rosso: il copricapo frigio dei rivoluzionari francesi.

Allora Cappuccetto rosso è soltanto una feroce satira politica e storica? Potrebbe, forse, se volessimo forzare la mano, e se volessimo dimenticare un fatto fondamentale: l’origine di quel cappello frigio. Dalla Rivoluzione francese veniamo catapultati indietro nei secoli dei secoli (e questo la dice lunga anche sui significati nascosti delle simbologie rivoluzionarie e in generale sul lessico storico/politico): il berretto frigio è uno dei copricapi o turbanti più arcaici e simbolici della storia, dai reconditi significati occulti. Esso veniva indossato dal sacerdote che officiava il culto di Mitra, ed è divenuto il modello di tutte le mitre sacerdotali o cerimoniali, incluse quelle cattoliche, dal non troppo remoto accenno fallico.
Si chiama frigio perché derivanti dalla Frigia, una regione dell’Asia minore, l’odierna Turchia. Era originariamente in pelle di capretto tinta poi di rosso: due zampe venivano appunto unite sotto il mento, e le altre due, riunite in alto, venivano poi lasciate ricadere in avanti sul capo. Il capretto è un eloquente simbolo del sacrificio. Sul culto mitraico si potrebbe scrivere a lungo, ma ci basterà dire che si tratta di un culto misterico di tipo solare, la cui origine è legata allo zoroastrismo e che si intreccerà in seguito con i culti europei della fertilità e le varie figure solari presenti nella storia mitica e filosofica d’Occidente.
Il riferimento alla fertilità ci conduce direttamente a un’altra interessante lettura del mitico cappuccio rosso: quello legato alle stagioni. Il cappuccio rosso, che contrasta col nero del lupo, sarebbe un riferimento al sempiterno ciclo delle stagioni, e dunque alla primavera: Cappuccetto Rosso sarebbe così una più recente Aurora omerica, la regina di Maggio di varie tradizioni culturali, non ultima quella cristiana (il mese di Maggio è infatti dedicato alla Madonna, moderna reginetta della primavera), celebrata anche da Shakespeare. Se vi interessa la cultura pop, della May Queen parlano anche i Led Zeppelin nella celebre Stairway to Heaven, solitamente collegata a un poema di Aleister Crowley.
Questo Cappuccio Rosso è in sintesi divenuto il simbolo della Libertà. I romani, contagiati dal mitraismo, lo donavanoagli schiavi liberati: i liberti. Ed è con questo spirito che i francesi lo indossarono a fine Settecento, e che prese piede in molti ambienti massonici che poi agirono politicamente nella storia ottocentesca e non solo (per questo lo troverete ancora oggi nello stemma di svariate nazioni).
La nostra bambina è allora un’anima in cerca di libertà? Libertà da cosa? E qual è il nesso con la Conoscenza, simboleggiata da portatori eccellenti ( i Re Magi, o il grande Puffo)?
Tuttavia non è chiaro in cosa consista questa libertà o questa conoscenza. I simboli alludono, ma non spiegano. Non si può capire, si deve vivere. Come Dorothy nel regno di Oz, bisogna seguire quel sentiero dorato percorrendolo di persona. In questo caso però Cappuccetto Rosso esce fuori dalla via già tracciata, ed è proprio così che incontra il Lupo.
Ma chi è poi questo Lupo?
Chi è questo essere terribile che lusinga, mente, inganna, sbrana, divora e uccide?
Sarà sicuramente un essere ignobile, ed è per quello che si nasconde con cura nella selva oscura, in cui la via retta è smarrita. Ma come Dante, a guardar bene è possibile cogliere altre cose in questa foresta apparentemente indecifrabile. Questo lupo sembra un’ombra: minaccioso ma inacciuffabile. Il termine ombra non è soltanto metaforico ma forse potrebbe cogliere qualche segno del vero.
In The Village di M. Night Shyamalan le bestie feroci nascoste nella foresta sono in realtà parte di quella tranquilla e dolce comunità in cui gli abitanti sono praticamente confinati. L’ombra dell’Uomo, come insegna Jung, è uno dei due poli da cui promana l’energia vitale, come accade nell’elettromagnetismo; essa non può dunque essere eliminata, pena l’eliminazione stessa dell’umano. Se rigettata, permane comunque come Doppio: è il nostro gemello nascosto, ignorato, negletto; è la metà oscura, che dà il titolo a un celebre romanzo di Stephen King (ma a cui in realtà lo stesso scrittore allude in moltissime delle sue opere).
Conoscere il Lupo è conoscere se stessi, diventare davvero un individuo. Il viaggio di Cappuccetto è così un viaggio socratico, di conoscenza interiore, o forse addirittura di nascita (il bruco scopre la sua vera natura diventando qualcos’altro).
Quindi il Lupo è solo una metafora, come molti pensano che sia l’Alchimia?
Nel film Cappuccetto Rosso Sangue il mito viene svolto come una storia dark di licantropi. Si tratta anche di un thriller/giallo poiché la protagonista deve scoprire chi tra i suoi conoscenti anche intimi sia il lupo. La trama però lascia spazio alla nostra psiche: il Lupo è l’altro, per quanto vicino a me.
Immaginiamo invece un altro panorama. La mia comunità è alla ricerca del temibile Lupo. Questi potrebbe essere mio padre, mio fratello, il mio fidanzato. Cerco di indagare, di scoprire chi possa essere. Finché una notte, in cui decido di affrontare il mistero e svelare l’identità segreta della Bestia, non scopro di essere io il Lupo. Sono io che la notte mi trasformo e divoro i miei cari. Sono io l’essere mostruoso, crudele, prepotente. Questa scoperta è così scioccante che la consapevolezza dura un istante. Il mio io si rifiuta di accettare tale Realtà. Il mio rifiuto, il trauma, mi ha scisso in due parti: quando ci sono io non c’è il Lupo, quando c’è il Lupo non ci sono io.
Finalmente, Jekill ha scoperto Hyde (hidden, nascosto).
I due sono facce della stessa cosa. Come riconciliarli?
L’io non deve ripudiare l’Ombra. Il rifiuto porta all’incoscienza: quando il Lupo comincia a svegliarsi, alla luce della Luna, Cappuccetto perde i sensi, scioccato dalla potenza, dalla ferinità di quella parte finora ignorata/ignota. Il Lupo agisce in assenza di consapevolezza, non regolato dall’io. E proprio quest’assenza lo rende pericoloso.
Nella serie televisiva C’era una volta Cappuccetto scopre l’esistenza di una comunità di licantropi che le insegna come gestire la propria natura. Per non essere succubi del proprio lato animale, dice una delle donne-lupo, bisogna ascoltarlo. Sentirlo, restare presenti. Solo così le due metà potranno riunirsi, e l’io non sarà più incosciente rispetto a quanto fa il Lupo.
Alla fine, noi umani siamo bambini a cui si racconta sempre la stessa storia, in salse diverse, con parole diverse, con voci diverse. Storia apparentemente fantasiosa che è sempre la nostra storia. Ascoltandola più e più volte (repetita iuvant), forse potremo un giorno giungere a riconoscerla svegliandoci dal torpore dell’incoscienza.
Scritto da: Valentina C.
SE VUOI SAPERNE DI PIU' SULLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE E IL PERCORSO CHE PROPONE, TI INVITIAMO A CONSULTARE LE SEGUENTI SEZIONI:
Se vuoi saperne di più sulla nostra organizzazione e il percorso che propone, ti invitiamo a consultare le seguenti sezioni:
Puoi anche contattarci al seguente indirizzo: info@centrokuun.it.SE TI E' PIACIUTO L'ARTICOLO CONDIVIDILO SUL TUO SOCIAL PREFERITO
QUALCHE PICCOLO CONSIGLIO DI LETTURA